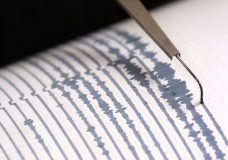Quanto ci mancano le lezioni dell’ Avvocato Agnelli!

C’è stato un tempo in cui l’Italia aveva un suo stile. Un suo portamento. Un suo modo — irripetibile — di coniugare potere e leggerezza, impresa e ironia, mondanità e serietà.
Un tempo in cui Gianni Agnelli, l’Avvocato per antonomasia, incarnava tutto questo come un monumento vivente: l’ultimo aristocratico in un Paese di arruffapopoli, l’ultimo liberale in una penisola sempre tentata dal conformismo di massa.
Lo so che i più giovani forse non sanno neppure chi sia, visto che i suoi eredi ai vertici dell’impero non portano neppure il suo cognome, bensì quello di Elkann, ma Gianni Agnelli è stato uno dei personaggi più emblematici del Novecento italiano, e non solo per il suo ruolo nell’economia e nella politica, ma anche per quella capacità tutta torinese di dire molto con poche parole.
Come pure so bene che “Gioanin lamiera”, come scherzosamente gli operai chiamavano l’Avvocato, ha succhiato di brutto; ma prima di lui ha succhiato suo padre; e prima di suo padre, suo nonno Giovanni Agnelli, il Fondatore della Fiat.
Hanno succhiato dallo Stato, cioè da tutti noi, con un salasso continuo; ma questa è un’altra storia, e non va ad intaccare il personaggio, di cui si ricordano in particolare le sue battute.
In uno dei suoi aforismi più celebri, Agnelli diceva: “In Italia la linea più breve fra due punti è l’arabesco.”
Una frase che sembra scritta ieri, per commentare l’iter tragicomico di qualunque riforma italiana: che si parli di giustizia, fisco, autonomia differenziata o fondi del Pnrr, il senso è sempre quello; rendere complicato ciò che altrove è semplice. Girare attorno al problema per non affrontarlo. Con un corollario: “In Italia le cose sono sempre più complicate di quanto sembrino, anche quando sembrano complicate”.
L’Avvocato non era un moralista, ma capiva bene che senza rigore il Paese si perdeva.
Lo diceva a modo suo: “Il potere logora chi ce l’ha.”
Un capovolgimento beffardo della massima andreottiana. Perché chi esercita davvero il potere in Italia, non i politicanti, ma i padroni di filiere e aziende, alla lunga ne paga il prezzo. Di critiche, di solitudine, talvolta di odio. Ed in un’epoca in cui nessuno vuole più farsi carico di nulla, questa battuta suona quasi profetica.
Poi certo, c’era chi lo criticava: troppo distante, troppo snob, troppo Fiat.
E lui, con una nonchalance da far impallidire Oscar Wilde, rispondeva: “I miei operai non mi amano, ma mi stimano.”
Provate oggi a chiedere a un lavoratore italiano se stima chi lo governa o chi lo rappresenta. Vi riderà in faccia, o vi tirerà una badilata, a seconda della zona geografica.
Agnelli era un uomo del Novecento, ma non un nostalgico. Aveva capito prima di tanti altri che il lavoro stava cambiando. Che il capitalismo industriale aveva bisogno di visione e non solo di produzione.
“Il problema non è dare lavoro a tutti. È trovare qualcuno che abbia voglia di lavorare”; lo diceva senza paternalismo, con quell’ironia torinese che nasconde l’inquietudine sotto una battuta.
Oggi, che ci scopriamo con milioni di inattivi, giovani scoraggiati e imprese che non trovano personale neanche a pagar oro, fa impressione pensare che l’Avvocato lo avesse già visto arrivare trent’anni fa.
Ma Gianni Agnelli era anche un uomo di bellezza, di sprezzatura, di eleganza come forma di disciplina morale.
“L’eleganza è una questione di educazione, non di portafoglio” soleva dire.
Dove sono finiti oggi quelli che hanno educazione?
Quelli che non confondono volgarità con popolarità?
In un’Italia dove il potere si misura in follower, e dove si urla per avere ragione, quella frase suona come il ricordo sbiadito di un Paese che fu. E che forse non sarà più.
Oggi chi è il vero erede dell’Avvocato?
Non parlo di cognomi, né di dinastie. Parlo di atteggiamento.
Di chi oggi, in mezzo alla polvere e al rumore, riesce ancora a vedere il quadro d’insieme. Di chi costruisce invece di lamentarsi. Di chi non si piange addosso, ma si rimbocca le maniche. Di chi sa che comandare non è gridare, ma scegliere, assumersi il peso, anche quando pesa.
Gianni Agnelli non era un santo. Ma era una bussola.
Ci diceva, con parole leggere, cose serissime, ci ricordava che lo stile non è un vezzo, ma un dovere, che l’Italia è un Paese difficile, ma non impossibile, che il potere, per essere legittimo, dev’essere discreto.
E che il futuro, come disse una volta con una punta di malinconia: “E’ una cosa da costruire, non da temere.”
Ecco, forse è questo che oggi ci manca di più: qualcuno che ci aiuti a non avere paura del futuro.
Magari con una battuta secca, con un sorriso sghembo, e con l’orologio portato sopra il polsino.
Tanto per ricordarci che si può essere profondi, anche senza essere pesanti.
La sua filosofia della vita la esprimeva con frasi tipo “Chi ha tempo non aspetti tempo. E chi non ha tempo… se lo prenda”, oppure “Preferisco la vita alla carriera”, una frase che riassume il suo amore per la bellezza, la velocità, la mondanità. Agnelli fu anche uno dei primi italiani a incarnare lo stile del jet set internazionale.
Per finire con un: “A 20 anni la vita è un’avventura, a 40 è un mestiere, a 60 una riflessione.”
Io immagino che se Gianni Agnelli vedesse l’Italia del 2025, tornerebbe subito a Saint-Moritz con il primo jet privato.
Ma non per snobismo. Per decenza.
E prima di partire, ci lascerebbe una delle sue sentenze secche come uno schiaffo in faccia: “La vera differenza tra l’Italia e l’America? Lì il futuro è un’opportunità, qui è un sospetto.”
E avrebbe ragione pure questa volta.
Noi, invece, restiamo qui, ad arabescare.
A chiamare “visione” ogni stronzata detta con tono grave.
A pensare che basti un bonus, un decreto, un jingle elettorale per risolvere il declino del Paese.
Ma credo di non poter chiudere davvero senza parlare del suo amore per la Juventus: perché era molto più che un presidente onorario o un tifoso eccellente. La Juve per lui era quasi una seconda famiglia, un’eredità morale e affettiva che andava ben oltre il business.
Agnelli era quello che telefonava la mattina presto a Trapattoni per commentare le formazioni, quello che con una battuta trasformava una sconfitta in leggenda o una vittoria in stile.
Ricordate quella frase su Platini? “È un re travestito da giocatore”.
Oppure quando disse che Del Piero (da lui sopranominato Pinturicchio) era un vero gentiluomo, anche se talvolta troppo educato per i difensori cattivi che incontrava.
Ogni sua parola sulla Juve era pesata, cesellata, lanciata come una massima.
Eppure non era mai stucchevole. Era innamorato, ma con ironia, con quella classe tutta torinese che riesce a essere passionale senza urlare.
Quando nel 1996 la Juventus vinse la Champions, pare che Agnelli, ormai quasi estraneo alle vicende aziendali, si commosse. Fu uno degli ultimi veri trionfi sotto il suo sguardo.
Il paradosso è che Gianni Agnelli era uno che stava sempre al di sopra delle parti, eppure quando si parlava di Juventus diventava partigiano, viscerale, sentimentalmente coinvolto come un ragazzino allo stadio.
Diceva: “La Juve è nel mio destino. Non potrei mai tifare per un’altra squadra.”
Questo era Gianni Agnelli, nel bene e nel male l’emblema dell’industria italiana del dopoguerra.
Presidente della FIAT, simbolo di potere economico, stile e influenza politica, ha incarnato per decenni l’alleanza tra capitalismo industriale, aristocrazia, e mondo istituzionale.
Una figura carismatica, modernizzatore a modo suo, fu un protagonista della Prima Repubblica, pur restando sempre dietro le quinte.
Juventus nel cuore, eleganza naturale, battute fulminanti.
Un mito italiano, controverso fin che si vuole, donnaiolo, amante degli sport estremi,…… ma indimenticabile.
Umberto Baldo