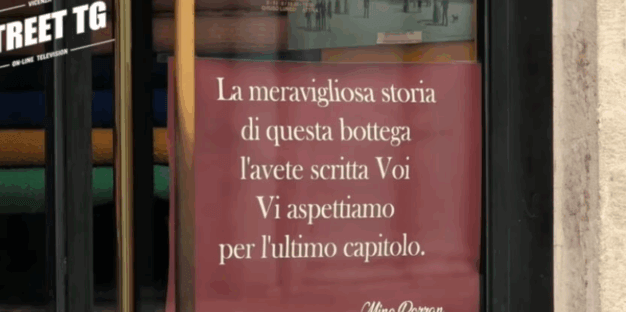I lamentatori seriali del web, che palle…

Di Alessandro Cammarano
C’è un rumore di fondo che accompagna ogni scroll, ogni clic, ogni notifica. Non è il brusio dei server né il fruscio degli spot pubblicitari, ma il borbottio ininterrotto dei lamentatori seriali del web: quella moltitudine instancabile di utenti che hanno fatto dell’obiezione un’arte, del “Sì, ma…” un inno nazionale, del malumore una bandiera da sventolare su ogni post.
Non hanno una causa precisa. Non si battono per un ideale. Si battono contro. Contro tutto, purché se ne parli. Lamentarsi, per loro, non è un gesto d’impazienza: è una vocazione. Sono i discepoli del dissenso perpetuo, i fedeli del contraddittorio universale.
Il web è diventato dunque la palestra del malcontento
Un tempo il lamento aveva una sua dignità. Bisognava guadagnarselo: recarsi al bar, trovare qualcuno disposto ad ascoltare, ordinare un caffè e magari perfino offrirlo; c’era uno sforzo, un rito sociale, un minimo di umanità.
Oggi basta un dito: il pollice opponibile, lo strumento evolutivo più sopravvalutato dell’era digitale.
Lamentarsi online è diventato uno sport da poltrona, un modo per restare in forma mentale senza mai staccarsi dal divano.
Ogni post è un pretesto: l’annuncio della scoperta di una nuova cura (“Sì, ma Big Pharma?”), un record sportivo (“Ai miei tempi si sudava di più”), una foto di un cane salvato dai pompieri (“E i gatti, allora?”). Nulla sfugge al radar del risentimento.
Il lamentatore seriale è convinto che il mondo intero complotti contro di lui. Se piove, è colpa del governo. Se c’è il sole, dell’inquinamento. Se non succede nulla, della noia.
La sua è una religione laica: non crede in Dio, ma crede fermamente che qualcuno stia sempre sbagliando qualcosa.
I lamentatori si muovono in branchi, colonizzano habitat digitali precisi, li marcano col segno del punto esclamativo multiplo e della tastiera infuocata.
Occupano militarmente i siti di informazione generalista. Ogni notizia è l’occasione per un commento indignato: “Ma nessuno ne parla!” — mentre lo stanno commentando in migliaia.
Colonizzano i gruppi di quartiere. “Chi ha parcheggiato davanti al mio passo carraio?” diventa in pochi minuti una riflessione sulla decadenza morale dell’Occidente.
Presidiano le pagine culturali. Un articolo sull’arte rinascimentale attira subito il genio che scrive: “Preferivo Banksy”.
Spadroneggiano nei gruppi enogastronomici, e le ricette sono il loro terreno di caccia preferito: “L’ho rifatta, ma ho tolto tutto e aggiunto altro. Molto meglio.”
Sono ovunque, ma non si organizzano mai: troppa fatica, troppa unanimità. Se provassero a fondare un partito, si dividerebbero subito: “Sì, ma non è questo il punto”.
Ma esiste un’anatomia di un lamentatore?
Fisicamente non lo distingui, ma lo riconosci subito dalle sue formule liturgiche:
“Non per essere polemico, però…”
“Senza offesa, ma…”
“Svegliatevi!!!”
“Io dico solo la verità.”
Il lamentatore è tuttologo per necessità: deve poter discutere di tutto. Passa con disinvoltura dalla politica estera alla temperatura del cappuccino, con lo stesso livello di competenza (basso) e lo stesso tono di autorità (altissimo).
È un professore immaginario, laureato all’università della propria esperienza personale, quella che “vale più di mille studi”.
La sua è una conoscenza orizzontale, come una pozzanghera dopo la pioggia: ampia, ma profonda un dito.
Eppure — e qui bisogna ammetterlo, senza ironia — dietro tanto livore c’è spesso un velo di malinconia.
Il lamentatore seriale è un nostalgico. Di cosa, non si sa: forse di un mondo in cui qualcuno lo ascoltava.
Forse del tempo in cui si poteva dire qualcosa senza essere subito smentiti da un algoritmo. Forse di se stesso, quando aveva ancora l’illusione che lamentarsi servisse a cambiare le cose, non solo a riempire il vuoto.
È deluso. Dal lavoro, dalla politica, dall’andamento della Serie A, dalla difficoltà di sentirsi parte di qualcosa. Il suo “non va bene niente” è un modo di dire “non va bene nessuno”, neppure io.
Ma questo, ovviamente, non lo scriverà mai. Preferirà digitare: “Che schifo!”
Immaginate un pianeta popolato solo da lamentatori.
Nessuna decisione verrebbe mai presa: ogni proposta verrebbe immediatamente demolita da un “Sì, ma…”.
I semafori resterebbero eternamente gialli, perché “il rosso è dittatoriale” e “il verde favorisce i privilegiati”.
Le università insegnerebbero solo “Storia del non sono d’accordo”.
Il telegiornale aprirebbe ogni sera con: “Tutto male, anche oggi.”
Un mondo coerente, almeno: l’apocalisse del disaccordo permanente.
La cura, per fortuna, esiste. Non passa dai corsi di comunicazione assertiva, né dagli psicologi digitali: si chiama silenzio.
Il silenzio online non è mutismo, è resistenza. È l’atto eroico di chi decide di non dire la sua, di lasciare che il tramonto resti un tramonto e non un complotto di Photoshop.
È la scelta di non commentare, non aggiungere, non correggere, non “mettere i puntini sulle i”.
Il silenzio, in tempi di iperconnessione, è il nuovo anticonformismo.
Il lamentatore, davanti a un silenzio, si disorienta. Non può litigare, non può correggere, non può sentirsi vivo nella contraddizione. È come un fuoco senza ossigeno: si spegne, fumando un po’.
Il mondo, nel frattempo, continua a girare. Le stagioni cambiano, le persone vivono, qualcuno ogni tanto è persino felice — senza dirlo.
E sotto a ogni post, tra centinaia di “ma non è proprio così”, c’è sempre un piccolo miracolo: un utente che legge e non commenta.
È il santo laico della rete, il martire della pazienza, l’ultimo romantico del buon senso.
A lui, e a tutti quelli che ancora sanno non ribattere, va il nostro grazie.
Perché in mezzo al chiasso dei lamentatori seriali, il suo silenzio — beato, sobrio, sovversivo — suona come una sinfonia.