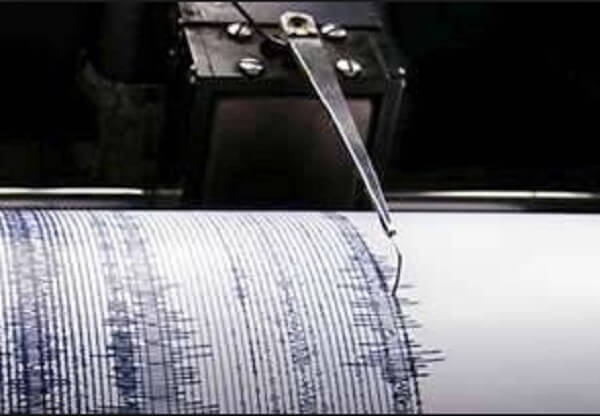Donald Trump, la Fed e l’idea pericolosa che tutti obbediscano

Umberto Baldo
Per mesi Jerome Powell ha incassato in silenzio. Ma gli insulti, le minacce, le pressioni dirette e indirette di Donald Trump, non hanno mai scalfito la maschera asciutta e severa del presidente della Federal Reserve.
Una figura quasi donchisciottesca: magro, anodino, apparentemente grigio. Poi, a metà dicembre, qualcosa si è rotto.
E Powell ha detto basta!
La miccia è stata l’apertura di un’indagine penale da parte della Procura Federale, formalmente dipendente dal Dipartimento di Giustizia.
Un atto che Powell ha letto per quello che, politicamente, è: una ritorsione.
Il prezzo da pagare per non essersi piegato alla volontà del Presidente degli Stati Uniti.
La vicenda dei sovraccosti per la ristrutturazione della storica sede della Fed – il Marriner S. Eccles Building, costruito nel 1930 e mai rinnovato prima – è solo il pretesto.
Da un budget iniziale di 1,8 miliardi si è passati a 2,5: una dinamica tutt’altro che eccezionale nei lavori pubblici americani.
Ma sufficiente per costruire un capo d’imputazione mediatico e politico.
A quel punto Powell ha scelto di uscire allo scoperto.
Un video, parole misurate ma durissime nella sostanza: l’indagine penale, ha detto, nasce dal fatto che la Federal Reserve prende decisioni sui tassi di interesse in base all’interesse generale, non alle preferenze del Presidente.
È il momento in cui la vicenda smette definitivamente di essere economica e diventa apertamente politica.
In gioco non c’è solo la politica monetaria, ma il perimetro stesso del potere presidenziale e la tenuta dei contrappesi democratici.
In altre parole: la linea di confine tra una democrazia liberale ed un potere personale senza freni.
Powell non è un rivoluzionario, né un eroe romantico. È, semmai, l’incarnazione dell’establishment istituzionale americano.
Nato 72 anni fa a Washington, repubblicano dichiarato fino a vent’anni fa, formazione impeccabile (Princeton, Georgetown), carriera nell’élite americana, studio legale privato, poi il Tesoro ai tempi del primo George Bush.
È stato Barack Obama a nominarlo nel board della Fed nel 2011, e Donald Trump a promuoverlo Presidente nel 2018 (sic!).
Una scelta che Trump ha presto vissuto come un errore: Powell non è uomo da obbedienza cieca.
Conservatore nei valori, sì, ma centrista, profondamente istituzionale, allergico all’idea che la Banca centrale diventi un’appendice della Casa Bianca.
Da qui l’escalation. Trump lo ha definito “idiota”, “imbecille o corrotto”, “mulo testardo”, “lento o ritardato”, arrivando a chiedersi pubblicamente se il vero nemico degli Stati Uniti fosse Powell o Xi Jinping.
Ha minacciato di licenziarlo, salvo poi fermarsi davanti agli avvertimenti dei legali della Casa Bianca sulle difficoltà giuridiche.
Ha allora cercato strade laterali, colpendo un’altra governatrice della Fed, Lisa Cook, accusata senza prove di irregolarità su un mutuo.
Anche lì, un nulla di fatto: i tribunali non gli hanno dato seguito.
Ora la parola passa addirittura alla Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi sui limiti dell’autorità presidenziale.
Ed è qui che la vicenda assume contorni inquietanti.
Perché quando un Presidente utilizza la leva giudiziaria per intimidire un’autorità indipendente, non siamo più nel terreno dello scontro politico, ma in quello dell’abuso di potere.
Il messaggio è chiaro: o ti allinei, o paghi.
È una logica estranea alla tradizione costituzionale americana, ma fin troppo familiare in altri contesti meno democratici.
Powell, che all’opinione pubblica appare spesso come un funzionario grigio e poco carismatico, in realtà ha giocato d’anticipo.
Da anni coltiva relazioni solide al Congresso, nel mondo finanziario e tra i banchieri centrali. Quando ha deciso di sfidare apertamente Trump sapeva di non essere solo.
Ed infatti la reazione è stata immediata.
Thom Tillis, senatore repubblicano e membro della Commissione bancaria del Senato, ha denunciato l’ingerenza della Casa Bianca e ha minacciato di bloccare le nomine alla Fed fino alla fine dell’indagine. Altri repubblicani hanno fatto lo stesso.
Persino il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha ricordato che l’indipendenza della Fed è una linea rossa.
Non solo. Tre ex presidenti della Federal Reserve – Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen – hanno firmato una dichiarazione congiunta in difesa di Powell, insieme ad economisti di primo piano ed ex Segretari al Tesoro di entrambi i partiti.
Dall’Europa è arrivato il sostegno della presidente della BCE, Christine Lagarde. E poi ci sono i mercati, che Trump tende a evocare solo quando gli danno ragione.
Jamie Dimon, numero uno di JPMorgan, è stato chiarissimo: erodere l’indipendenza della Fed non è una buona idea.
Tradotto: giocare con la credibilità della Banca Centrale significa giocare con il fuoco.
Questo fronte compatto ha spiazzato Trump.
Il Segretario al Tesoro lo ha messo in guardia dagli effetti sui mercati e sulle future nomine al Senato. Trump ha provato a smarcarsi, sostenendo di non sapere nulla dell’indagine.
Ma la tregua è durata poco: due giorni dopo è tornato ad attaccare Powell, salvo poi dichiarare di non avere “motivi” per licenziarlo.
Un passo avanti e uno indietro, come spesso accade quando il potere incontra un limite che non può facilmente abbattere.
Il tempo, però, stringe. Il mandato di Powell come presidente della Fed scade a maggio, anche se resterà nel board fino al 2028.
Tradizionalmente chi lascia la presidenza si dimette anche dal consiglio, ma l’ostilità aperta di Trump potrebbe spingerlo a restare, guidando un fronte interno di resistenza.
Se invece se ne andasse, lascerebbe campo libero alla Casa Bianca per aumentare la propria influenza ai vertici della Banca centrale.
Anche la successione è diventata un terreno minato.
Il favorito iniziale, Kevin Hassett, appare troppo allineato per superare il vaglio del Senato. Prende quota Kevin Warsh, economista ed ex membro del Consiglio dei Governatori della Fed.
Ma il punto non è il nome. Il punto è il principio.
Perché questa storia non riguarda solo gli Stati Uniti.
Riguarda tutte le democrazie liberali che credono nella separazione dei poteri, nei contrappesi, nell’idea – oggi sempre più sotto attacco – che l’economia non possa essere governata a colpi di tweet o di vendette personali.
Powell non è un tribuno del popolo, né un paladino ideologico.
È semplicemente un servitore delle Istituzioni che ha deciso di non arretrare.
Ed è qui la lezione, anche per noi europei, anche per noi italiani.
Le Istituzioni funzionano finché qualcuno è disposto a difenderle, anche quando diventano scomode.
Quando nessuno lo fa più, quando tutto viene piegato alla volontà del capo di turno, la democrazia non crolla all’improvviso: si sfilaccia, un pezzo alla volta.
Trump è convinto che, alla fine, la spunterà.
Ma c’è un giudice che non si può intimidire né insultare: i mercati.
E, prima ancora, la storia.
Su quel terreno, di solito, l’arroganza del potere presenta sempre il conto.
Umberto Baldo