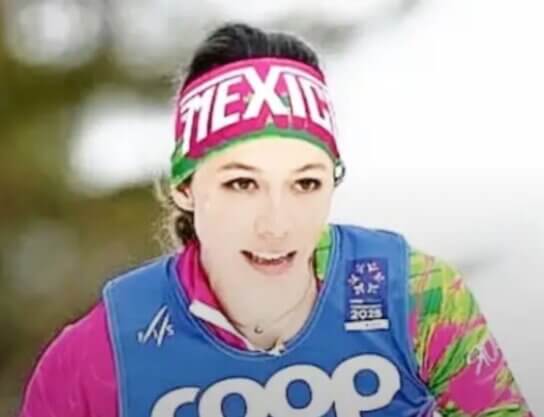Una nonna, un uovo, un gesto d’amore. Lo sbatudìn non si ordinava. Si riceveva.

Ho sentito parlare in questi giorni del “gelato veneto della rinascita”: un prodotto innovativo creato dai nostri gelatai, che combina il tradizionale “sbatudìn” con un passito veneto e biscotti artigianali.
Quel nome, “sbatudìn”, ha riacceso in me ricordi che pensavo archiviati per sempre.
Ricordi che hanno il sapore delle emozioni: pieni di luce gialla, di cucine con la stufa accesa, di tovaglie cerate, di nonne con il grembiule e le mani grandi.
Perché lo sbatudìn non era solo un cibo.
Era un gesto, oserei dire quasi un rito.
Era la nonna che ti guardava e diceva, in dialetto, che eri un po’ sciupato (forse non a caso in Veneto per riferirsi ad una persona stanca, provata, si dice “sbatùo).
Anche se magari eri solo triste per un brutto voto o per un ginocchio sbucciato.
Era la mamma che, senza manuali di nutrizione, sapeva che un tuorlo fresco ed un cucchiaio di zucchero potevano rimettere in moto un bambino.
Altro che barrette proteiche con nomi inglesi, stampati in caratteri aggressivi.
Qui bastava un uovo del pollaio e un po’ di “olio di gomito”.
Il rito era semplice. Si rompeva l’uovo, e si separava il tuorlo. Lo si metteva in un bicchiere o in una scodella; poi lo zucchero, poco alla volta.
E via a sbattere. Con decisione. Con amore. Con pazienza.
Non c’erano fruste elettriche. C’era un braccio che girava, che si stancava, che non delegava.
Era tempo vero, non accelerato.
Sotto gli occhi del bambino accadeva una magia: quel rosso intenso diventava chiaro, spumoso, cremoso.
Un piccolo sole in tazza.
Non era solo nutrimento. Era protezione.
Come accennato, in Veneto aveva un nome preciso: sbatudìn.
Sono convinto che lo si facesse in tutta Italia, ma qui aveva una sua identità, un suono domestico.
Lo sbatudìn non si ordinava. Si riceveva.
Quando volevano darti qualcosa di diverso, magari di nascosto aggiungevano un goccio di caffè.
Quando invece eri un po’ più grande, un’ombra di Marsala (non un’ “ombra” in senso tecnico, alla veneta eh!), e per somma goduria, un savoiardo da intingere.
E poi, diciamolo con chiarezza, perché oggi si fa una confusione degna di un talk show: lo sbatudìn non è lo zabaione.
Gli ingredienti possono sembrare parenti stretti.
Tuorlo e zucchero da una parte, tuorlo e zucchero dall’altra. Ma la parentela finisce lì.
Lo sbatudìn è artigianale, immediato, domestico.
Un cucchiaio, un braccio allenato, e cinque minuti di vita vera.
Lo zabaione è un’altra storia.
Richiede attenzione, tecnica, tempo.
È una crema cotta lentamente a bagnomaria, con l’aggiunta di vino o Marsala.
È un dolce da cucina strutturata, non da tavolo di legno con la nonna che ti osserva.
Non è un caso se dello zabaione si cerchi di individuare le origini in secoli lontani. C’è chi racconta che la ricetta risalga al 1471 e sia stata creata dal capitano di ventura Giovan Paolo Baglioni; altri la collocano nella Torino del XVI secolo; altri ancora fanno derivare il nome da “zabaja”, bevanda dolce proveniente dalla costa illirica e consumata a Venezia.
Lo zabaione ha bisogno di storia, lo sbatudìn no.
Lo sbatudìn nasce crudo, diretto, sincero, lo zabaione nasce cotto, montato, elaborato.
Il primo è carezza. L’altro è dessert.
E non è una gara. Sono due mondi diversi.
Certo, oggi qualcuno arriccia il naso. salmonella, zucchero, colesterolo.
Probabilmente hanno anche ragione. Oggi sappiamo tutto: calorie, indice glicemico, microbiota. Abbiamo integratori per ogni carenza, tabelle per ogni età, applicazioni che contano i passi e perfino i sospiri.
Eppure abbiamo bambini più ansiosi ed adulti più fragili.
Non perché manchi la vitamina D, ma perché manca qualcuno che abbia la voglia ed il tempo per sbatterti un tuorlo guardandoti amorevolmente negli occhi.
C’è una differenza sottile tra nutrizione e memoria.
La nutrizione si misura con le analisi del sangue, la memoria no.
Lo sbatudin era il ricostituente dei bambini un po’ giù, degli studenti prima degli esami, dei nipoti che arrivavano in campagna per l’estate.
Era il modo con cui una generazione, senza parole sofisticate, diceva: ti voglio bene, e voglio vederti forte.
In altre parole, non era un prodotto; era tempo donato.
Non costava nulla. Non era da ricchi. Non era esotico.
Era alla portata di tutti.
Un tuorlo, un cucchiaio di zucchero, una mano che sbatte.
Ma dentro c’era molto più di quello che oggi riusciamo a comprare nei supermercati.
Lo sbatudìn non guariva tutto, ma faceva sentire al sicuro.
E per un bambino, è quasi la stessa cosa.