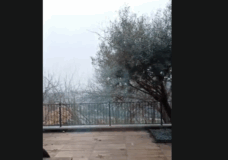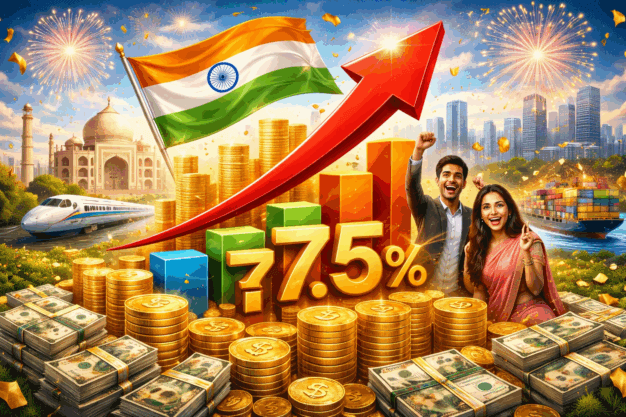Quando il carrello pesa più del Pil: la crisi silenziosa dei supermercati

Umberto Baldo
Capisco la fatica: ogni giorno Venezuela, Groenlandia, Nato, scenari globali e mappe strategiche.
Per una volta abbassiamo lo sguardo.
Dal planisfero al carrello della spesa.
Perché, alla fine, se non mangiamo, di geopolitica ce ne facciamo poco.
Parliamo dunque dei supermercati, o ipermercati, o “experience store”, o come diavolo decidano di chiamarsi oggi.
Il tema non è banale, perché da più parti si comincia a parlare apertamente di crisi della grande distribuzione: punti vendita che chiudono, bilanci in sofferenza (Carrefour docet), concorrenza feroce, costi operativi fuori controllo e consumatori che, guarda un po’, hanno cambiato abitudini.
Aggiungete E-commerce, inflazione, stipendi fermi; tutte cose che, stranamente, qualcuno sembra aver scoperto solo adesso.
Eppure non molti anni fa ci avevano raccontato che il supermercato era il “migliore dei mondi possibili”: futuro radioso, modello irreversibile, progresso in corsia quattro.
E per un po’ è stato anche vero. Adesso però, i nodi stanno arrivando al pettine.
Premessa doverosa: la mia è una ricostruzione da uomo della strada, senza alcuna presunzione di essere una verità rivelata.
Ma spesso l’uomo della strada vede cose che i Consigli di amministrazione fingono di ignorare.
Cominciamo da un dato elementare: il numero dei punti vendita.
La grande distribuzione ha fatto più o meno quello che fecero le Banche qualche decennio fa: sportelli ovunque, anche uno di fronte all’altro, salvo poi accorgersi che il gioco non valeva la candela, ed iniziare a chiudere a raffica.
Negli ultimi anni i supermercati hanno aperto sempre nuove strutture, come se la popolazione fosse in crescita esponenziale.
Peccato che gli abitanti non aumentino. Ed allora succede una cosa molto semplice: dividendo il numero dei cittadini per quello dei supermercati, scopri che ogni punto vendita ha sempre meno clienti potenziali.
È inutile raccontarsela: i consumatori non fanno la spesa in dieci supermercati diversi.
O comprano poco dappertutto, o restano fedeli al solito.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: si rubano i clienti tra loro e guadagnano tutti meno.
A complicare il quadro è arrivata l’avanzata dei discount.
Che non sono più i magazzini tristi con la merce negli scatoloni, ma supermercati a tutti gli effetti: puliti, ordinati, assortiti, spesso indistinguibili – per struttura e offerta – da quelli “delle catene più “titolate”.
La loro forza è una formula tanto semplice quanto efficace: prezzi bassi grazie a una logistica efficiente, meno marche, molta sostanza.
Un’offerta che si è allargata e qualificata, attirando non solo chi deve risparmiare per forza, ma anche chi vuole semplicemente spendere meglio.
In tempi di inflazione, il rapporto qualità-prezzo diventa quasi una virtù morale.
E qui vengo ad un’esperienza personale, che immagino sia sempre meno solo mia.
Da qualche tempo guardo le etichette.
E non per le calorie o i grassi, ma per capire dove e da chi il prodotto viene realizzato.
Sapete cosa si scopre talvolta?
Che lo stabilimento di produzione è lo stesso sia per il prodotto “di marca”, quello reclamizzato a suon di spot, sia per il prodotto “da discount”, che nessuno pubblicizza.
Li compri, li assaggi; ed in molti casi, francamente, non trovi una grande differenza “organolettica”, e allora fatalmente sei portato a chiederti: perché una disparità di prezzo così marcata?
Come già detto, non pretendo di avere la verità in tasca.
Ma il successo crescente dei discount mi suggerisce che questa mia sensazione deve essere condivisa da molti.
Poi c’è il fattore decisivo, quello che qualcuno continua a trattare come una variabile temporanea: il calo del potere d’acquisto.
Prima o poi doveva colpire anche i beni di prima necessità.
Con un Pil che galleggia intorno allo zero virgola, consumi inchiodati ai decimali e stipendi fermi, la coperta si accorcia.
E il 2025 appena chiuso non è stato certo un anno brillante per la grande distribuzione.
La clientela dei supermercati è in larga parte ceto medio-basso, già schiacciato da bollette, affitti, carburanti e spese quotidiane.
È quindi inevitabile che anche la spesa diventi un campo di battaglia.
E qui si apre un altro fenomeno, forse sottovalutato: il “consumatore tattico”.
Quello che entra in un supermercato, compra solo le offerte, riempie mezzo carrello, e poi va altrove a cercare prezzi migliori per il resto. Fedeltà zero, margini evaporati.
In questo scenario, il formato supermercato, o meglio ipermercato – simbolo per decenni della modernizzazione dei consumi – mostra tutte le sue crepe.
Nato negli anni Ottanta sull’onda del modello francese, puntava su assortimenti sterminati e su un’idea di abbondanza permanente.
Oggi quel modello appare sempre più fuori tempo.
Margini erosi, discount in avanzata, potere d’acquisto in caduta, concorrenza specializzata, digitalizzazione spesso tardiva: l’equilibrio della grande distribuzione organizzata italiana si è rotto.
Non è solo una fase difficile; è una transizione strutturale.
Il formato ipermercato arretra, sostituito da soluzioni più piccole, ibride, flessibili.
In questo contesto si discute in questi giorni se sia il caso di chiudere i supermercati la domenica per ridurre i costi.
Ho l’impressione che sia poco più di un pannicello caldo.
Il problema non è l’orario.
Il problema è che il “migliore dei mondi possibili” non esiste più.
E continuare a far finta di nulla, anche tra le corsie illuminate a giorno, non servirà a salvarlo.
Umberto Baldo