Le suggestioni di Antonveneta sull’inchiesta milanese Mps-Mediobanca
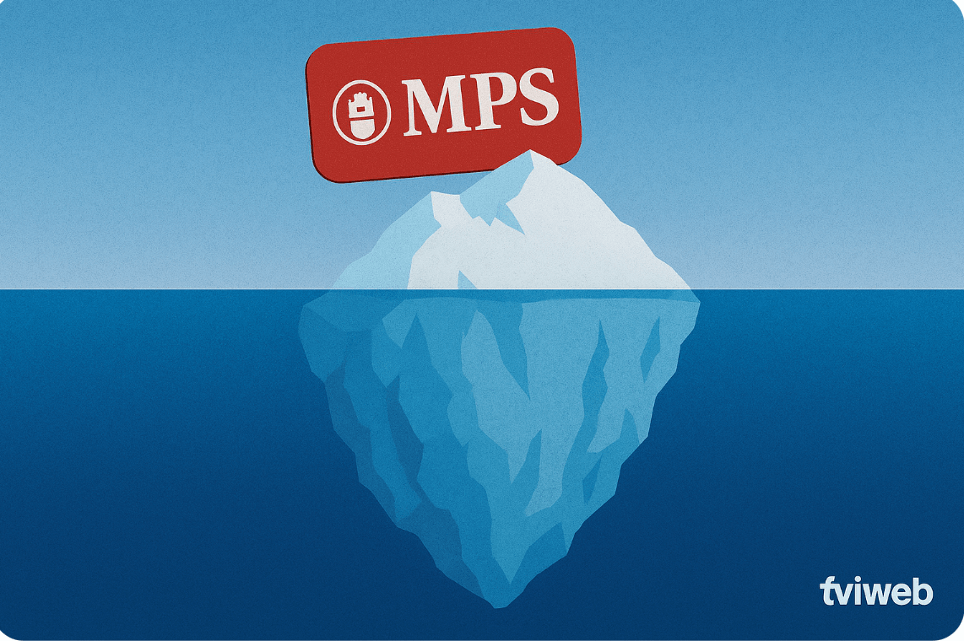
Umberto Baldo
Ci sono momenti nella storia finanziaria italiana che sembrano uscire da una sceneggiatura comica, se non fosse che parliamo di miliardi, posti di lavoro, e della credibilità di un intero sistema.
La vicenda di Banca Antonveneta, tra il 2004 e il 2005, appartiene a questa categoria: una storia di scalate pasticciate, ambizioni smisurate, ed un manipolo di “nuovi ricchi” romani convinti di poter conquistare una Banca veneta come se stessero comprando un attico ai Parioli.
Antonveneta non era una meteora.
Era una Banca ben radicata nel Nord-Est produttivo, con bilanci dignitosi e una reputazione sobria, anche se la morte di Silvano Pontello nel 2002 la privò dello slancio che ne aveva caratterizzato gli anni della grande crescita.
Ed è proprio per questo che diventò l’obiettivo perfetto della finanza creativa che in quegli anni si muoveva tra Milano due, i salotti romani ed i telefoni cellulari sempre caldi.
A guidare la carica allora c’era Giampiero Fiorani, il dominus della Banca Popolare Italiana, uomo di Banca nel senso più esteso e disinvolto del termine.
Accanto a lui, una compagnia di giro che sembrava assemblata da un casting director con molto senso dell’umorismo: Stefano Ricucci, immobiliarista dal linguaggio colorito e dall’autostima sovrabbondante (venuto dal basso, diploma da odontoiatra, arricchitosi velocemente, molto velocemente nel campo delle speculazioni edilizie) Emilio Gnutti, finanziere bresciano con più vite di un gatto, ed in sottofondo il coro dei vari Coppola, Statuto, Consorte (soprannominato ‘il Cuccia rosso’, Amministratore di Unipol) e compagnia cantante.
Ma la vera benzina nel motore arrivò da un palazzo che avrebbe dovuto rappresentare l’esatto opposto delle avventure improvvisate: la Banca d’Italia.
Il Governatore Antonio Fazio, infastidito dall’idea che gli olandesi di ABN Amro potessero mettere le mani su Antonveneta, decise di “difendere l’italianità” della banca.
Notate come quello dell’ “italianità” sia un concetto sempre presente nella politica romana, tanto da indurre di recente il Governo Meloni a definire banca straniera il Gruppo Unicredit.
L’idea non sarebbe stata nemmeno sbagliata di per sé, se non fosse che Fazio la mise in pratica con un attivismo degno di un procuratore sportivo.
Telefonate, favoritismi, autorizzazioni rallentate per gli stranieri ed accelerate per gli amici italiani: una scena che oggi farebbe saltare dalla sedia qualsiasi regolatore internazionale (io lo definirei un esempio di “finanza creativa alla romana”).
Per realizzare la scalata, Fiorani e soci misero in piedi una rete di partecipazioni opache, prestiti incrociati, società parcheggio, fondi amici, e la Banca stessa usata come un salvadanaio privato.
Tutto pur di “fare massa critica” e soffiare Antonveneta agli olandesi.
Le intercettazioni dell’epoca, ascoltate oggi, sembrano il copione di una commedia dell’assurdo: una finanza che parlava di miliardi con la stessa leggerezza con cui si discute della ristrutturazione del terrazzo.
Questa compagnia di gentiluomini è passata alla storia con il nome di “Furbetti del quartierino”
La definizione, poi diventata proverbiale, descriveva perfettamente l’operazione.
Non c’era un grande piano industriale, non c’era una visione strategica, non c’era nemmeno un coordinamento vero.
C’era solo l’idea — tipicamente italiana — che “tra amici” tutto sia possibile: compreso comprare una Banca grande quanto una provincia.
Anche se, con il senno di poi, bisogna dire che se i furbetti fossero riusciti nei loro rispettivi tentativi di acquisizione di Banche e società, l’intero assetto dell’economia e dell’informazione – e quindi della politica – del nostro Paese sarebbe stato radicalmente stravolto.
Il problema è che quando mancano competenze e capitali veri, ad un certo punto arriva la realtà a bussare.
E quando ha bussato, ha buttato giù la porta.
Quando la Magistratura entrò in scena, il castello di carte crollò in poche settimane.
Fiorani fu arrestato, Ricucci (la moglie Anna Falchi lo lasciò subito), e altri vennero travolti dalle inchieste, Antonio Fazio, pressato da ogni parte, fu costretto a lasciare la guida della Banca d’Italia.
Io la ricordo bene, perché c’ero, quella drammatica assemblea alla Fiera di Padova che doveva incoronare Fiorani e furbetti, ma che fu stoppata all’ultimo minuto dall’intervento dei Magistrati.
E gli olandesi?
Alla fine si comprarono Antonveneta lo stesso, pagando un prezzo stellare e portandosi a casa l’istituto veneto (un boccone di quelli che ti rimangono sul gozzo, e ti mandano al tappeto).
Una partita finanziaria che doveva segnare l’ “orgoglio italiano” finì così per diventare l’emblema della nostra incapacità di fare sistema quando serve davvero.
Ora, sia chiaro: la storia non si ripete mai uguale.
I contesti cambiano, i personaggi sono diversi, le condizioni politiche e sociali di oggi non hanno nulla a che vedere con quelle di vent’anni fa.
E per essere chiaro fino in fondo: non intendo assolutamente mettere in relazione i “Furbetti del quartierino’”di allora con i protagonisti di oggi.
Fiorani, Ricucci e compagnia erano un’altra storia, un altro mondo, un’altra caratura morale.
Caltagirone, Míleri, Lovaglio — piaccia o non piaccia — appartengono ad una categoria completamente diversa, con profili professionali, solidità finanziaria, ed obiettivi che nulla hanno a che vedere con le improvvisazioni di vent’anni fa.
Le analogie che riaffiorano in me riguardano il contesto, non le persone.
Perché certe dinamiche sembrano un po’ ricorrere.
O quanto meno, ad un osservatore attempato come me, fanno inevitabilmente tornare alla memoria vecchi schemi, vecchi climi.
Non è colpa di nessuno se, leggendo dell’inchiesta della procura di Milano sull’operazione Mps–Mediobanca, in chi visse la vicenda Antonveneta in prima persona riaffiorano echi di quel passato, echi sia chiaro, non similitudini, ed anche qualche suggestione.
Ma per un motivo più semplice e più generale: ogni volta che da Roma parte un’operazione per “mettere ordine” o “prendere posizione” nella finanza del Nord, le cose tendono a complicarsi.
È un fatto storico, quasi sociologico, prima ancora che giudiziario: il tentativo di forzare equilibri consolidati – quelli che da sempre reggevano gli incastri tra Mediobanca, le partecipazioni incrociate, le Assicurazioni Generali, le Banche territoriali, i salotti più o meno buoni – spesso porta più problemi che vantaggi.
Non è questione di colpe, ma di sistemi che reagiscono.
A volte si difendono, a volte si spezzano.
E quando si spezzano, l’onda d’urto finisce nelle aule dei Tribunali.
Ecco perché, senza tirare conclusioni affrettate, e senza paragonare vicende che hanno natura e portata completamente diverse, qualche analogia nella struttura dello schema è difficile da ignorare: e mi riferisco all’idea ricorrente che si possa “ridisegnare” un pezzo di potere finanziario del Nord partendo da stanze romane – politiche, burocratiche o manageriali che siano.
Una tentazione che raramente ha portato fortuna.
La prudenza, nei commenti e nei giudizi, oggi è d’obbligo.
Siamo in una fase in cui la Magistratura deve poter portare a termine l’inchiesta; ovviamente tutti i soggetti coinvolti hanno diritto alla tutela e nessuno merita processi in piazza.
Ma una riflessione sulla fragilità del nostro sistema finanziario, esposto ciclicamente agli stessi rischi, quella possiamo farla eccome.
E magari ricordarci che, in Italia, la finanza del Nord è sempre stata una bestia difficile da cavalcare, soprattutto per chi pensa di poterla addomesticare da lontano.
Umberto Baldo



















































