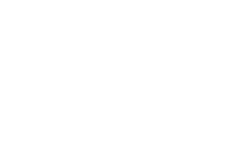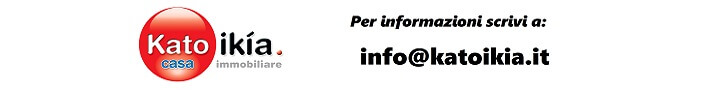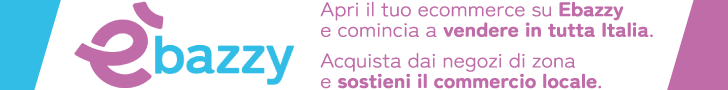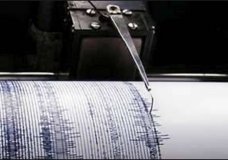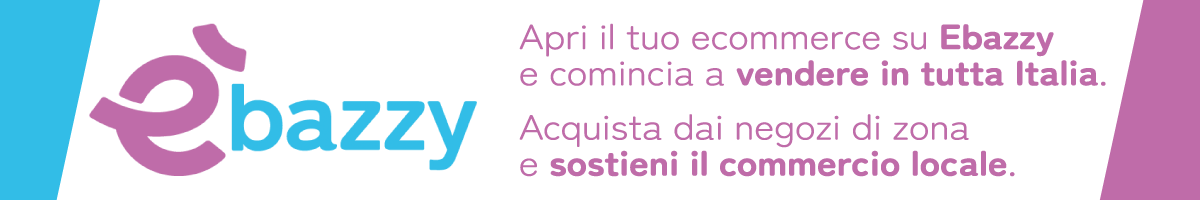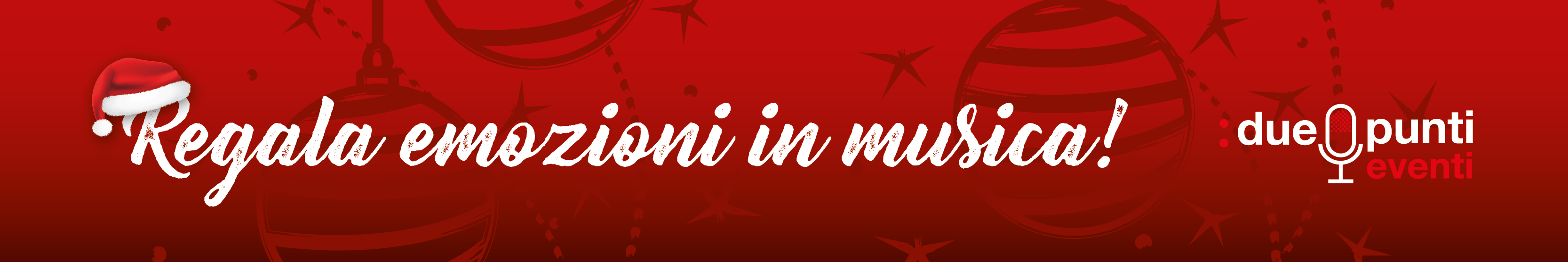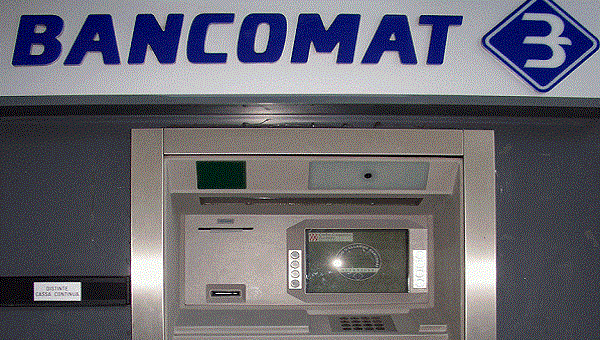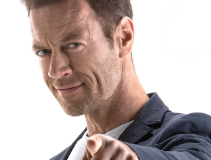PASSAGGIO A NORD – Uomo e natura: perché le fiabe devono diventare realtà ai tempi del coronavirus

“Io credo questo: le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna”(Italio Calvino)
Andrà tutto bene: in questi momenti più che mai abbiamo bisogno di credere nel lieto fine. Da sempre le fiabe ci danno coraggio, ci insegnano a superare le nostre paure, ad essere positivi e a non perdere mai le speranze. Ci dimostrano che dopo l’oscurità, ritorna sempre la luce e che non esiste prova insuperabile perché a tutto c’è rimedio. Ci raccontano storie dove l’unione fa la forza e dove il bene trionfa sempre sul male, malgrado le avversità. Ci insegnano che se crediamo davvero in qualcosa, se combattiamo davvero per i nostri sogni, è possibile cambiare il mondo. Ci ricordano che le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze, nel bene e nel male. La magia delle fiabe sta anche nel loro grande potere educativo: da sempre tramandano un’antica saggezza e ci donano preziosi insegnamenti, capaci di farci crescere e accompagnarci nelle sfide quotidiane. Ecco che oggi allora, per andare avanti, dobbiamo guardare anche indietro, a quei bambini che ascoltavano con fiducia le fiabe che raccontavano i grandi, e domandarci se siamo diventati gli eroi o i cattivi della storia dell’umanità.
Guardare indietro per andare
avanti
Sergio
Bonato, Presidente dell’Istituto di Cultura Cimbra di Roana, scrive di una
fiaba diffusa in tutto l’arco alpino con diverse varianti che «racconta di
esseri fantastici che convivevano con le genti di montagna, facevano loro
compagnia nel camminare quotidiano, con i piedi rivolti all’indietro, così che
sembravano arretrare, andare indietro, quando avanzavano e andavano avanti. Non
si sa se era confusione, scherzo, inganno, oppure sapienza e intuizione più
profonda. Questa fiaba voleva significare che per affrontare il futuro, il
nuovo, l’imprevedibile è necessario basarsi sulla saggezza acquisita nel
passato, è necessario tenere conto anche del patrimonio di immaginario popolare
sedimentato lungo i secoli: esso costitutiva una forza potente che aiutava ad
affrontare la vita dura e faticosa in montagna». Ed è proprio nella tradizione
popolare dei Sette Comuni che fiabe e leggende occupano un posto rilevante: i
racconti di orchi, sanguinelli, beate donnette, streghe, animali ed alberi
parlanti, erano profondamente legati all’ambiente circostante e da essi
traspariva un senso di paura, sottomissione e riverenza nei confronti delle
forze naturali, così come di intima profondità con tutti gli esseri viventi. Se
il vento e il temporale erano temuti, la pioggia era considerata un dono del
cielo per la fertilità dei campi e la vita. Secondo la testimonianza di
Agostino Dal Pozzo, nell’immaginario popolare «la terra, l’aria, l’acqua, il
fuoco, ogni astro, ogni stagione, le valli, i monti, le grotte, le selve e
perfino ogni specie di animali, tutto insomma aveva il suo spirito tutelare».
Così le fiabe e le leggende dell’Altopiano dei Sette Comuni davano vita ad un
mondo fantastico che «si accendeva nel silenzio e nella solitudine di tante
esistenze umane – racconta Bonato nel libro “I Cimbri dei Sette Comuni” – che
cercavano un po’ di sicurezza e protezione, esorcizzando paure e
contraddizioni, attraverso simbologie sacrali e riferimenti magici strettamente
connessi con la realtà ambientale». È facile in questi giorni difficili
riconoscerci nei nostri antenati che, proprio nelle fiabe, cercavano la
risposta a bisogni profondi di magia e speranza.
Cosa ci insegna il passato
Un
tempo l’uomo viveva in perfetta armonia con la natura, sapeva che dalle sue
generose risorse dipendeva la sua stessa sopravvivenza e per questo la temeva e
rispettava. Com’è andata poi la storia lo sappiamo tutti, anche se le fiabe non
ce l’hanno raccontato: l’equilibrio si è rotto e, a poco a poco, l’essere umano
ha cominciato, da un lato, a sfruttare sempre più la natura, dall’altro a
danneggiarla con i propri comportamenti. Proprio in questi giorni il rapporto
del WWF Italia, “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli
ecosistemi”, suggerisce che sia presente un collegamento diretto fra le azioni
dell’uomo e alcune malattie. Il ruolo che gli ecosistemi naturali avrebbero nel
regolare la trasmissione e la diffusione di malattie infettive come le zoonosi
e quindi, nel sostenere e alimentare la vita, compresa quella della nostra
specie, sarebbe infatti fondamentale. Se «la distruzione di habitat e di
biodiversità provocata dall’uomo rompe gli equilibri ecologici in grado di
contrastare i microrganismi responsabili di alcune malattie, e crea condizioni
favorevoli alla loro diffusione», allora è anche attraverso la difesa della
natura che si può tutelare la salute umana.
La morale di questa fiaba? Senz’altro che c’è ancora speranza e che, se tutti
insieme ci impegniamo fin da subito per il bene nostro e quello del nostro
pianeta, un giorno potremmo raccontare ai nostri figli: “C’era una volta un
mostro di nome Coronavirus, ma uniti l’abbiamo sconfitto”.